MARIATERESA SARTORI
Venezia, 1961
- Boulder – collettiva | GMR, Giudecca, Venezia | 15.11.2025 – 15.01.2026
- Comunicato Stampa
- Disegno singolare – mostra collettiva a cura di Elio Grazioli | Galleria Frittelli Rizzo, Milano | 3.10 – 4.12.2025
- Comunicato Stampa
- David Rickard, Mariateresa Sartori – AETHER / ETERE la presenza dell’assente | GMR, Venice | 19.07 – 28.09.2024
- Comunicato Stampa
- (in)visible fields. space as energy – mostra collettiva
- Comunicato Stampa
- Assembramenti – mostra collettiva
- Comunicato Stampa
- Gesti di Carta – online
- Comunicato Stampa
- RE-INDEX / SPACE AND TIME DURING ISOLATION – online
- Comunicato Stampa
- Soglie e Limiti – mostra collettiva
- Comunicato Stampa
- Mariateresa Sartori, You are the music while the music lasts
- Comunicato Stampa
- Personality – mostra collettiva
- Comunicato Stampa
- Antoni Muntadas e Mariateresa Sartori, Movimenti e Situazioni
- Comunicato Stampa
- Latitudini | Longitudini – mostra collettiva
- Comunicato Stampa
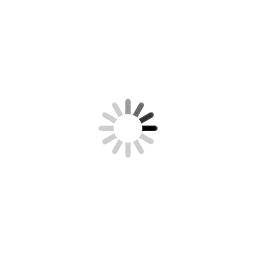
[siteorigin_widget class="WidgetController_bwg"][/siteorigin_widget]
Opening 15 novembre 2025 ore 12:00
15 novembre 2025 - 15 gennaio 2026
Martedì - Sabato 13:00 - 18:00
GMR, Giudecca 800 Q
La Galleria Michela Rizzo è lieta di presentare Boulder, la mostra collettiva che andrà a concludere il percorso espositivo nella sede degli ex birrifici. La mostra, che inaugurerà sabato 15 novembre 2025 alle ore 12:00, vedrà in dialogo l’opera di Hamish Fulton con quelle di Matthew Attard, Ivan Barlafante, Michael Höpfner, Francesco Jodice, Ryts Monet, Maurizio Pellegrin, Cesare Pietroiusti, David Rickard, Antonio Rovaldi, Mariateresa Sartori, Claudio Tesser e Silvano Tessarollo.
Boulders nasce dall’opera Boulder di Hamish Fulton, artista britannico che ha fatto del cammino un linguaggio artistico e un atto di consapevolezza. Basato sull’esperienza diretta del paesaggio e su una concezione radicale del rapporto tra arte e natura, il lavoro di Fulton diventa il punto di partenza per un dialogo corale e intergenerazionale attorno al simbolo del masso, emblema di forza, permanenza e memoria del paesaggio.
All’interno di questo orizzonte, gli artisti in mostra si dispongono secondo differenti gradi di prossimità al pensiero di Fulton. Michael Höpfner e Antonio Rovaldi ne condividono in modo più diretto l’approccio esperienziale e meditativo: entrambi indagano il cammino come strumento di conoscenza e di immersione nel paesaggio, restituendone la dimensione fisica e interiore attraverso disegni, fotografie e installazioni.
Più laterali ma profondamente affini nella tensione poetica sono Mariateresa Sartori, Matthew Attard e Ivan Barlafante, che traducono il rapporto con la natura in linguaggi di percezione e di pensiero. Sartori presenta una grande installazione realizzata con la tecnica del frottage, dedicata alle materie di sassi e sabbie, accompagnata da un libro che intreccia sguardo artistico e osservazione scientifica. Attard, attraverso il disegno e l’uso del pen plotter, trasforma scansioni tridimensionali di massi in tracciati grafici che fondono precisione digitale e intervento manuale, esplorando i limiti della percezione e dell’immagine.
Attorno a questi nuclei si raccolgono artisti che, pur partendo da linguaggi e prospettive differenti, ampliano la riflessione sul legame tra uomo, natura e spazio. David Rickard esplora le relazioni materiali e percettive tra architettura e ambiente; Ryts Monet, Maurizio Pellegrin, Cesare Pietroiusti e Francesco Jodice offrono visioni concettuali e narrative che aprono il tema del paesaggio a nuove geografie culturali e sociali. In particolare, Jodice presenta un’opera di grandi dimensioni tratta dal progetto WEST, un viaggio attraverso le città nate durante la corsa all’oro e oggi abbandonate, in cui il paesaggio diventa archivio di utopie e fallimenti.
Silvano Tessarollo e Claudio Tesser propongono lavori in cui la natura si rivela nella sua fragile concretezza, tra memoria, tempo e trasformazione. A fare da fulcro alla mostra saranno due wall painting di Hamish Fulton, Glacial Boulder e Rivisiting The Boulders, che occuperanno una parte significativa dello spazio, conferendo forma e respiro all’intero progetto.
Con Boulder, la Galleria Michela Rizzo conclude una stagione importante del proprio percorso alla Giudecca, affidando all’immagine del masso – saldo e immobile ma al tempo stesso plasmato dal tempo – il compito di custodire la memoria di un luogo e di un tempo condiviso. Un approdo che è anche una soglia: l’ultimo passo prima di una nuova direzione.
Mariateresa Sartori nasce a Venezia nel 1961 dove vive e lavora. Si laurea in germanistica con una tesi su Freud e la psicologia dell’arte. La sua ricerca si muove attorno tre fulcri tematici: il metodo scientifico empirico, le dinamiche comportamentali spesso in relazione con le neuro-scienze, la musica e il suono in relazione con il linguaggio. La tensione tra oggettivo e soggettivo, tra unicità degli eventi e teoria generale nutre tutta la sua ricerca che spesso si avvale della collaborazione di esperti delle discipline nelle quali si addentra: geologi, fisici teorici, linguisti, musicologi, musicisti, cantanti, attori, botanici, ornitologi... Il dato reale viene empiricamente rilevato e in seguito analizzato da angolazioni che variano da lavoro a lavoro e che approdano ad esiti diversi, dal video al disegno, dalla fotografia stenopeica all’opera sonora. La tensione “verso” preme all’artista non il raggiungimento, se mai fosse possibile, dell’oggettività. Nel 2024 ha esposto in una mostra collettiva con David Rikard, intitolata “Aether/Etere. La presenza dell’assente”, a cura di Riccardo Greco, presso la Galleria Michela Rizzo, Venezia. Nel 2023, ha presentato una mostra personale intitolata "Vento: SW 2km/h, debole, Lodi 28 ottobre 2023", curata da Carlo Orsini, presso Platea Palazzo Galeano, Lodi. Nello stesso anno, Sartori ha partecipato alla Biennale Mosaico di Ravenna con l’opera "L’aria ha un peso", curata da Luca Donelli. A Monaco ha realizzato la performance "Der Klang der Sprache/The Sound of Language", esposta prima come performance dal vivo alla Münchener Kammerspiel e poi come installazione sonora presso l’Habibi Kiosk, nel 2023; entrambe le opere sono a cura di Gina Penzkofer. Nel 2021, Sartori ha collaborato con il compositore Paolo Marzocchi per la performance "The Sound of Dante", tenutasi in vari contesti internazionali, tra cui Berlino, Mosca e Venezia. Nel 2019 ha esposto "Telling Time", un progetto in dialogo con Roman Opalka alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia, curata da Chiara Bertola. Negli anni precedenti ha presentato mostre come "You are the music while the music lasts", presso la Galleria Michela Rizzo, nel 2013 e "Omaggio a Chopin", presso la Greenhouse at the Giardini Venice Biennale, nel 2011, le quali dimostrano la lunga carriera di Sartori nel confrontarsi con musica e linguaggio, due temi centrali del suo lavoro.